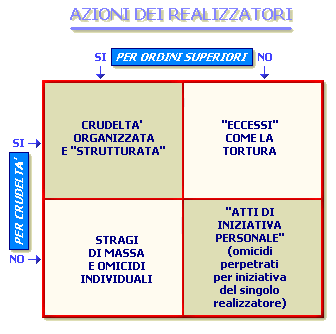|
Con il termine "operazionismo", ci si riferisce alle ricostruzioni dello sterminio degli ebrei d'Europa che non si sono anzitutto preoccupate di comprendere "perché", ma "come" esso sia avvenuto.
Lo storico che ha maggiormente contribuito a impostare in questa direzione lo studio della "soluzione finale" è Raoul Hilberg, autore di un'opera monumentale [cfr. Hilberg, 1985], che viene considerata unanimemente la più importante sull'intera questione. Hilberg, politologo formatosi alla Columbia University sotto la guida di Franz Neumann, ebreo tedesco emigrato negli Stati Uniti nel 1933, presenta così l'obiettivo della propria ricerca:
«[...] volevo esplorare il nudo meccanismo della distruzione dall'interno del suo stesso funzionamento; e più mi immergevo nel problema, più mi accorgevo che mi ero avviato nello studio di un processo organizzativo, messo in atto da burocrati a capo di una macchina amministrativa che coinvolgeva un intero continente. Comprendere di che cosa fosse costituito questo apparato e come riuscisse ad assicurarsi le sue diverse funzioni, divenne lo scopo principale della mia vita» [Hilberg, 1985, vol. I, p.
XIX].
La tesi di Hilberg è che la distruzione degli
ebrei abbia conosciuto quattro fasi progressive: un processo di
definizione ideologica e giuridica degli ebrei, l'espropriazione dei beni,
la concentrazione e la deportazione, lo sterminio. Di queste fasi, secondo
Hilberg non fu responsabile un solo individuo o un gruppo ristretto di
persone, ma l'intero apparato amministrativo dello Stato tedesco:
«L'operazione non venne affidata ad un unico agente: la macchina della distruzione fu sempre un aggregato di parti diverse. Senza dubbio un settore determinato può avere svolto, in alcuni momenti, un ruolo di supervisione (federführende) nella messa in opera di una certa direttiva, ma non ci fu mai un organismo centrale incaricato di dirigere o di coordinare da solo l'insieme del processo. L'apparato della distruzione si estendeva in ogni angolo; era diversificato e, prima di tutto, decentrato» [Hilberg, 1985, pp.
53-54].
Se questa tesi di Hilberg è corretta (e le circa mille pagine di documentazione che questo storico ha pubblicato sono piuttosto convincenti), sembrerebbe che l'ipotesi funzionalista abbia trovato nell'analisi minuziosa dei meccanismi operativi della "soluzione finale" una sostanziale conferma, benché Hilberg non dia a vedere di appassionarsi alle diatribe tra "intenzionalisti" e "funzionalisti" a proposito del ruolo di
Hitler.
La vicinanza tra le posizioni di Hilberg e quelle dei funzionalisti non è tuttavia un caso isolato: anche Christopher Browning, che del resto è sempre stato restio a identificarsi completamente con i funzionalisti, in anni recenti è approdato all'opzione metodologica di Hilberg (indagare dall'interno il meccanismo dello sterminio, anziché porsi domande aprioristiche sulle ragioni per cui avvenne).
Browning ha tuttavia spostato il campo d'osservazione sulla micro-realtà dello sterminio, piuttosto che sul funzionamento della macchina nel suo insieme, indagando i comportamenti operativi di un battaglione di polizia tedesca di stanza in Polonia, che partecipò attivamente ai massacri mediante fucilazione di decine di migliaia di ebrei [Browning, 1992].
Con questa delimitazione di campo, è stato possibile a Browning incominciare ad affrontare in modo rigoroso il nocciolo del problema, ovvero la questione della colpa e delle responsabilità. Indagando i comportamenti dei poliziotti riservisti tedeschi (responsabili, tra l'altro, del più grande massacro di ebrei avvenuto nella Polonia occupata: 35.000 civili fucilati in due giorni - 3 e 4 novembre 1943 - nel campo di transito di Majdanek, nei pressi di Lublino), spesso attraverso l'incrocio delle loro stesse dichiarazioni, rese nel dopoguerra alla magistratura tedesca, Browning ha potuto dimostrare in modo convincente che la questione della colpa non è delimitabile a un gruppo di individui, ma è imputabile alla società tedesca degli anni Quaranta nel suo insieme.
Questa conclusione è condivisa dall'autore del più recente tra gli studi "operazionisti" del problema: Daniel Jonah Goldhagen, autore di un volume che ha suscitato un dibattito infuocato in Germania proprio sulla questione della colpa (la Schuldfrage, come la chiamò nell'immediato dopoguerra il filosofo ebreo tedesco Karl Jaspers).
Nel suo studio, Goldhagen ha ripreso l'opzione metodologica di Hilberg e il campo d'osservazione di Browning. Il suo scopo principale non è quello di ricostruire il funzionamento della macchina nel suo insieme, ma piuttosto di comprendere il ruolo che nella "soluzione finale" hanno avuto i «tedeschi comuni» [Goldhagen, 1996]. Pur rifutando espressamente il concetto di "colpa collettiva", Goldhagen individua nella larga condivisione sociale di un delirante pregiudizio antisemita il fattore determinante che spinse uomini comuni, che spesso erano stati, prima dell'avvento del regime nazista, avversari del nazismo stesso, a compiere individualmente azioni criminali che avrebbero potuto senza alcuna difficoltà evitare. Goldhagen si sofferma in particolare su due aspetti della questione che hanno suscitato diverse controversie sin dal 1945: il problema dell'obbedienza e quello della crudeltà.
Già ai processi di Norimberga del 1945, la linea difensiva adottata da molti criminali di guerra fu quella di richiamarsi al dovere di obbedienza che vincola un militare che riceve un ordine. Vi fu anche chi sostenne di avere ucciso per non essere a sua volta fucilato per disobbedienza agli ordini. Goldhagen, con abbondanza di documentazione, riesce tuttavia a dimostrare non solo che mai vi furono casi di militari fucilati per non avere ucciso ebrei: egli trova ulteriori conferme ad un fatto già accertato da Browning, ovvero che nei battaglioni di polizia tedesca era esplicitamente consentito sottrarsi alle operazioni più cruente contro i civili ebrei (ricavandone talvolta addirittura dei privilegi, come il rimpatrio dai territori occupati della Polonia e la destinazione a incarichi di tutta tranquillità), ma che, ciò nonostante, furono pochissimi i poliziotti che cercarono di sottrarsi alle operazioni di massacro [cfr. Goldhagen, 1996, pp.193-294].
Il problema della crudeltà con la quale i tedeschi eseguivano le operazioni di distruzione della popolazione ebraica (donne e bambini compresi) orienta ancor più radicalmente verso l'idea di una "colpa" diffusa, di un coinvolgimento totale dei "tedeschi comuni" nelle responsabilità dello sterminio.
Per sintetizzare l'intera questione, Goldhagen elabora una rappresentazione grafica di questo genere:
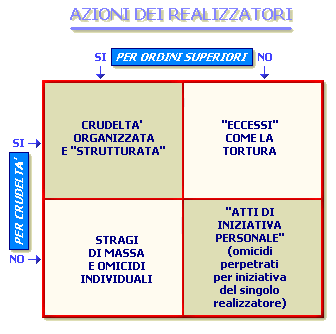
Dallo schema emerge con chiarezza il fatto che alcune forme di crudeltà (quelle "strutturate", cioé derivanti dall'organizzazione del sistema persecutorio) non sono riconducibili soltanto a responsabilità individuali, ma anche alla esecuzione di ordini superiori. Nell'eseguire tali ordini, tuttavia, i realizzatori materiali dello sterminio che non hanno fatto nulla per sottrarsi al compito loro assegnato si sono resi corresponsabili di crudeltà inaudite.
Per spiegare questo fenomeno possiamo ricorrere soltanto a due spiegazioni: o tra i tedeschi vissuti negli anni Quaranta era presente un tasso di psicopatologie sadiche decisamente superiore alla media di qualunque altro Paese e di qualunque altra epoca, oppure concludiamo, con Goldhagen, che la crudeltà verso gli ebrei non veniva percepita dai tedeschi come tale, poiché il violento e radicato pregiudizio antisemita oscurava e neutralizzava qualunque forma di coscienza morale [cfr. Goldhagen, 1996, pp. 431-471].
Ciò non significa che si possa realmente parlare di una "colpa collettiva" del popolo tedesco, oppure giustificare l'intero fenomeno ascrivendolo ad un presunto "carattere nazionale tedesco", che favorirebbe una sorta di coazione a obbedire all'autorità costituita (altra giustificazione addotta da molti avvocati difensori dei criminali di guerra ai processi di Norimberga del 1945). Per il primo punto, anche Goldhagen osserva che la colpa è sempre individuale e per il secondo ricorda come negli anni della repubblica di Weimar molti dei responsabili della "soluzione finale", Hitler incluso, si opposero anche con le armi all'autorità costituita.
CONCLUSIONE
L'autore dell'ipertesto, come ha già ripetutamente dichiarato altrove, propende per le conclusioni cui sono giunti gli storici "operazionisti". Il giudizio storico, proprio perché non coincide con l'emissione di una sentenza giudiziaria, non può accontentarsi di teorie sostenibili, che "funzionano", ma che non spiegano.
Qualunque tentativo di restringere le responsabilità o di allargarle troppo renderebbe giustificabile il fenomeno della distruzione degli ebrei d'Europa. Sostenere, come talvolta è stato fatto, che Hitler era pazzo (e che solo da lui dipese, in ultima analisi, la distruzione degli ebrei), oppure sostenere che i tedeschi dell'età moderna avrebbero sviluppato caratteristiche psicologiche tipiche delle patologie sado-masochiste [cfr. Fromm, 1941, pp. 181-206], conduce a esiti paradossali. Infatti, se un individuo o una società sono preda di malattie mentali, il loro comportamento esclude a priori qualunque responsabilità. In essi è la malattia che determina il comportamento, non la volontà o la coscienza morale.
Ma le azioni documentate in questo ipertesto, per quanto ripugnanti possano apparire, sono state compiute da uomini normali, banali, ordinari, in pieno possesso delle loro facoltà mentali. Di tali azioni quegli uomini sono stati pienamente, meticolosamente responsabili, almeno sino a quando sono stati chiamati in giudizio per renderne conto.
|